Stanco (di Stefano Pistolini)

Stefano Pistolini
Giornalista e Scrittore, Produttore e Autore TV
La nostra prima volta. Nel 1986 quando lavoravamo per organizzare la prima festa della FGCI della rifondazione a Napoli. Molti anni dopo l’ho ritrovato con qualche chilo in più, ma più affabile e concreto.
Stanco
California. 1995.
La foto. C’era tutto. Il deserto. I rovi che rotolavano inseguendo la polvere che saliva in cielo. Il caldo torrido che si potevano cuocere le uova sul cofano della nostra macchina. Il distributore di benzina era il centro di quel mondo surreale. L’America tra la California e l’Arizona come l’avevo sempre sognata.
In un posto così, lungo la linea malferma della frontiera sud degli Stati Uniti col Messico, m’è successa la cosa più stupida che può accaderti laggiù. Sono rimasto senza benzina. Ci sono troppi distributori, dappertutto, così rassicuranti da farti sempre rinviare la fermata per il pieno. Poi, al momento del bisogno, spariscono. E ti ritrovi come uno stupido, sulla strada che conduce alle città yin e yang, Calexico e Mexicali, col serbatoio vuoto e la voglia di sbattere la testa sul volante. Per fortuna, se fai un cenno al bordo della strada, là si fermano subito per capire di cosa hai bisogno. Infatti, la prima macchina che passa, un pickup male in arnese, inchioda a pochi metri da me. Scende un uomo anziano, cappello a falda larga, baffi bianchi, jeans, camicia chiara. Bastano due parole e parte il pragmatismo americano: non ti preoccupare, ti accompagno alla pompa e ti fai dare una tanica di benzina. Poi ti riaccompagno qua. Non ho da fare. Quando comincio a profondermi in ringraziamenti, taglia corto: non è un disturbo, stavo andando in paese a vedere se c’è qualche diavolo in giro. Per sdebitarti, mi offrirai un caffè, you’ll buy me a coffee. Arriviamo alla stazione di servizio, provvede a farsi dare un contenitore e a farlo riempire con dieci dollari di benzina. Torniamo alla macchina, prende un’imbuto dal pianale e la travasa senza farne cadere una goccia, io dietro che guardo. Quando ha finito, vorrei offrirgli il pranzo. Glielo dico, si toglie il cappello, si gratta la testa e risponde che con quel caldo ha voglia solo di caffè, per birre e burritos meglio aspettare sera. Lo seguo, di nuovo verso il paese e parcheggio accanto a lui a un diner. Entriamo, c’è una donna grassa al bancone e un paio di avventori solitari. Ci mettiamo in un separé, ordina il caffè e comincia a parlare. E’ di questo che ha voglia. Qualcuno che l’ascolti. Anche uno straniero sconosciuto. Parla lentamente, con lunghe pause, durante le quali percorre l’ambiente con lo sguardo. Si chiama Jay, sulla settantina, in pensione, trent’anni nell’ufficio dello sceriffo, prima di pattuglia, poi alle scartoffie. Però, tutta la sua vita è rimasta impigliata ai diciotto mesi passati in guerra, spedito in Vietnam, subito in prima linea. Rievoca quei giorni in modo sconnesso, frammentario, senza interpellarmi. Passa in rassegna nomi di compagni e di luoghi che non ha scordato: dove morì quello, dove andò a un passo dal lasciarci la pelle, dove passava i weekend nelle retrovie, con le ragazze del posto. Non ha mai capito perché fosse finito laggiù, a far cosa e perché. C’è andato perché gliel’hanno ordinato e l’America è così, sei tu da solo, ma sei parte del tutto. Racconta, poi le parole si diradano. Alla fine si riscuote, io sto in silenzio di fronte a lui, ho perso il senso del tempo. Si scusa, dice che quando gli capita di ricordare, non si ferma più. Dice che a questo punto il caffè lo deve pagare lui. Io m’inalbero. No. Almeno il caffè. Grazie per le confidenze. Sono incontri così, che valgono la pena. Lui annuisce, per un momento pare commosso. Ciascuno rimonta sulla sua macchina. Partiamo in due direzioni diverse.



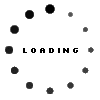
Commenti recenti