Gemelle (di Franco Minganti)
Ago 03, 17


Docente UniversitarioLa nostra prima volta. Suonava il jazz su un palco negli anni ’70. Siamo diventati amici negli anni ’90. Negli anni ’10 ci vediamo poco. Si occupa sempre di cose assai stimolanti per il cervello.GemelleNew York, 1988La foto. Erano lì… e, ancora oggi, quando arrivi non le vedi, stai male.

Manhattan, New York. 1988
Di fronte all’ineludibile presenza di questa fotografia non si può non iniziare parlando al passato… ci sono cose da ricapitolare. 1988: da una quindicina d’anni le torri gemelle del World Trade Center non erano più l’edificio più alto del mondo. Avevano perso il primato di fronte alla performance della Willis Tower – allora Sears Tower – di Chicago, antenne in cima. La storia si ripeteva: senza l’antenna per le teletrasmissioni neanche loro ce l’avrebbero fatta a superare l’Empire State Building (proverbialmente warholiano, almeno per me), pure lui dotato di un’appendice che a un certo punto della progettazione era stata pensata per l’attracco dei dirigibili. Già, perchè i grattacieli degli anni trenta venivano immaginati, proiettati verso un futuro neanche troppo lontano, come potenziali aereoporti urbani… ben curiosa, profetica coincidenza con la realtà di quell’incongrua e letteralmente terminale pista d’atterraggio in cui due Boeing 767 avrebbero trasformato la Torre Nord e la Torre Sud del WTC l’11 settembre 2001.
Il compito affidatomi da Claudio è impervio, scabroso, sdrucciolevole: devo fare i conti con una iconicità assoluta e con un’iconografia esplosa e survoltata che non appartiene più ai singoli ma al mondo. Per fortuna possiamo lavorare per sottrazione. Entrambi. Il fotografo ed io. Lui deve averlo già fatto, allora, quando scattava. Io lo farò a momenti… forse.
Per cominciare, perchè fotografare le torri? Voglio dire, perchè fotografarle allora, nel 1988? Perchè erano già l’epitome di New York, ed anzi molto di più? Perchè era una prima volta a New York e chissà quali e quante inquadrature impressionate sulla pellicola originale precedevano e seguivano questo scatto? Perchè erano alte? Perchè erano due, identiche, ma se ne parlava come di un unico edificio? Perchè… perchè… ma perchè fotografarle così?
L’inquadratura taglia l’altezza a torri già alte. Al fotografo non interessa il respiro della messa in quadro della verticalità, lo spazio del cielo sopra New York: zac… e l’antenna è mozzata. Che cosa viene messo in scena qui, allora? La gemellarità, forse? La vertigine della gemellarità con l’oltraggioso eccesso del bino identico? L’inquietante doppelgängerheit? La tensione verso un ideale – etico, estetico, religioso – che punta alla perfezione o al freak totale? In Dreaming of Babylon (1977) Richard Brautigan suggeriva, per quanto scalcinato potesse suonare, che la combinazione perfetta nome-cognome per il patronimico Smith fosse Smith Smith… c’entrerà? O c’entrerà piuttosto una (possibilmente improbabile) eco del celebre scatto Identical Twins, Roselle, New Jersey, 1967 di Diane Arbus, tuffo senza rete nella freakishness profonda dell’americanità popolare?
Nel 1988 l’immaginario occidentale delle torri gemelle doveva già circolare abbondantemente a colori e allora swoosh, via il colore ed evviva questo bianco e nero almeno un po’ livido e sgranato. Quell’immaginario aveva l’evidenza tridimensionale di una sfida allo spazio, con prospettive anche sghembe che restituivano la sia pur leggera differenza delle due, la loro separatezza obbligata. E allora zip, via la profondità ed evviva la misurazione frontale, a vista: le due torri sono proprio alte uguali, una accanto all’altra, spalla contro spalla. Richiamano alla mente, prepotentemente, i due profili in rilievo lucido, appena percettibile ed anzi quasi invisibile, della celeberrima cover tutta nera del New Yorker del 24 settembre 2001 concepita da Art Spiegelman: le sagome sono quelle di uno scorcio in prospettiva, costrette tuttavia alla bidimensionalità senza profondità della copertina della rivista annegata nel buio del lutto.
Curioso, ho scritto di Icaro e Dedalo (figlio volante e padre progettista), dell’ideale complementarità tra architettura e volo – meglio, luoghi alti e progettazione urbana, e olistica ricognizione aerea – ma, come a volte mi capita, scrivo di cose che frequento solo “da lontano”, che studio con circospezione, a rassicurante distanza di sicurezza. Probabilmente ho anche paura di soffrire di vertigini. Insomma: in 35 anni di frequentazioni newyorkesi non sono mai salito sulle torri, non ne ho mai avvertito l’urgenza – sapeste quanto artatamente indotta dalle guide turistiche, oggi più di ieri, persino in absentia – e anzi devo aver elaborato degli anticorpi che mi hanno tenuto lontano da lì e me le hanno fatte disconoscere e persino osteggiare quasi quanto l’Empire. Se è per quello, sempre meglio il Chrysler Building o il Flatiron, lì in zona, addensati nel mio personale immaginario da lunghe, ispirate osservazioni in presenza e da memorabili interpretazioni cinematografiche (due su tutte: in Q di Larry Cohen, film del 1982, con il nido del serpente volante in cima al Chrysler e il volto strepitoso di Michael Moriarty, e in certe brevissime sequenze Mutoscope & Biograph del 1902 a registrare l’inizio della parabola del Flatiron, da gigante a nano dello skyline newyorkese). E meglio comunque la “storia di Wall Street” del melvilliano Bartleby the Scrivener… roba del 1853.
Certo, vicinissimo al World Trade Center c’ero già passato, ospite per un paio di giorni a casa di un’amica che mi aveva raccontato come dalle sue finestre avesse potuto assistere alla vicenda del primo attentato alle torri nel febbraio del 1993, quello del camion di esplosivo parcheggiato nel garage sotto la Torre Nord e fatto esplodere. Pur da testimone oculare del caos, aveva poi saputo solo dalla tv a quale pericolo lei e suo figlio fossero scampati. Se i media italiani ne avevano ovviamente parlato, da noi l’allarme era stato come neutralizzato, ma lì, a due passi dall’inferno, la mia amica si era molto spaventata e aveva deciso che avrebbe traslocato appena possibile.
Il teleobiettivo schiaccia quel gran Lego che è New York contro le torri e, più indietro, contro l’Hudson con le scie di traghetti e rimorchiatori, e il Jersey Shore. Magari quelli in lontananza sono i primi contrafforti delle Catskill Mountains dell’irvinghiano Rip Van Winkle, misterioso almeno quanto Bartleby, chissà. Sotto le gemelle, in basso, davanti quasi a coprir loro i piedi, campeggia oscuro e inquietante (col senno di poi) il Building-7, quello vaporizzato come la Nord e la Sud, solo parecchio tempo dopo di loro e, apparentemente, senza motivo, tanto da farne l’unico grattacielo di acciaio al mondo collassato a causa di un incendio. A pianta trapezoidale e ricoperto di granito rosa, la sua ingloriosa fine avrebbe scatenato cospirazionisti e dietrologi che propendono per un’autodistruzione procurata, forti del fatto che il palazzo ospitasse branche dei servizi segreti statunitensi.
Se socchiudo gli occhi, è come se gli spigoli delle gemelle, abbacinati dal sole, tagliassero la tela come uno degli interventi “pittorici” di Lucio Fontana, riproponendo comunque la verticalità come coordinata che guida l’occhio. Forme pure: i riquadri delle vetrate quasi non si distinguono, come fusi nel grigio del corpo delle torri. Sulla cima di quella a sinistra pare intravedersi un’attività lillipuziana, ma è un’illusione dettata dalla trasgressione di una visione che non vuole rassegnarsi a confrontarsi unicamente con pareti e cornici di finestre, in assenza di quell’attività umana che dovrà pure brulicare, dietro (è vero, in basso lo scorcio di uno dei canyon di Manhattan lascia immaginare, più che scorgere, traffico automobilistico). Allo stesso modo, il mio sguardo assennatamente rifiuta di cavalcare l’idea che stiamo guardando dei fantasmi, ectoplasmi che in un qualche momento hanno impressionato una pellicola ma che non potremmo certo ri-fotografare altrimenti. Forse è solo la tenue traccia di un umano esorcizzare la morte. E qui si addensano senso ed emozione: non si tratta della sparizione “controllata” di un edificio, come in certe surreali sequenze di Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio, 1982), ma della scomparsa delle persone implose lì dentro, non quelle spettacolari e derealizzate che volteggiano leggere nel cielo diNew York, consegnate poi agli esercizi letterari e cinematografici che ci hanno impegnato dopo.
Che dire di più?


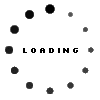
Commenti recenti